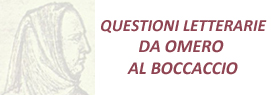Sul Domenicale del 19 luglio 2015 è apparso un articolo di Martin West intitolato Le deviazioni di Ulisse, preceduto da una breve introduzione di Dorella Cianci: il grecista inglese scomparso di recente a 77 anni “ha fatto conoscere al mondo i nuovi versi di Saffo da lui scoperti e tradotti in inglese”: Eccone la versione italiana della filologa: Il mio cuore è cresciuto pesante, le mie ginocchia non mi sostengono / loro che una volta erano agili per la danza come quelle dei cerbiatti.
West scrive che, avendo convissuto per cinquant’anni con due sorelle maggiori, l’Iliade e l’Odissea, è rimasto affascinato soprattutto dalla loro anatomia: i due diversi poeti che per lo studioso lavorarono a lungo sulla struttura dei poemi “devono aver proceduto allo sviluppo di nuove idee nel corso del processo creativo, elaborando nuovi materiali da includere ed introducendo quelle modifiche che essi desiderarono apportare ai progetti originali”.
Non si tratterebbe quindi di “poeti orali che avrebbero composto oralmente le proprie opere”, secondo “la visione più largamente condivisa dalla critica delle ultime due generazioni”. Neanche è ammissibile l’ipotesi, avanzata nella prima metà del Novecento dall’americano Parry e dal suo assistente Lord, in base alla quale i due poemi tramandati oralmente sarebbero stati “dettati per un certo numero di giorni consecutivamente, e pertanto registrati, da poeti orali”.
West pensa invece all’opera di un poeta che realizzò “nel corso di molti anni un poema caratterizzato da espansioni dovute all’inserimento di numerosi episodi secondari” e per dimostrarlo propone un abbozzo del disegno che ritiene essere alla base della genesi dell’Odissea: fra la seconda metà dell’ottavo secolo e l’inizio del settimo l’epica ionica nel suo momento di splendore vide il fiorire di poeti orali che, accompagnandosi con la lira a quattro corde, “ricantavano le leggende della tradizione, in particolare quelle relative alla guerra di Troia”.
Non mi soffermo a riassumere quello che secondo Martin West potrebbe essere stato essere il lavoro di integrazione e espansione del poema dovuto all’accoglimento di episodi paralleli a quelli compresi nel progetto originario, provenienti soprattutto dall’Asia centrale, che portano Odìsseo a subire ritardi e deviazioni nel suo viaggio di ritorno. Senza dubbio l’Odissea “colpisce con una ventata di freschezza ed inventiva, ma anche con la sensazione che non ogni parte sia stata adeguatamente incorporata e armonizzata, con la sensazione, cioè, che il prodotto che ci viene posto dinanzi agli occhi non sia del tutto perfetto né completamente finito, ma soltanto quasi perfetto e quasi finito”. Tuttavia “nella forma in cui l’opera ci si presenta, la sensazione che abbiamo è di riuscire a dare una sbirciata nel laboratorio del poeta e vedere così il dipanarsi di cose meravigliose”.
Siccome io la penso in modo molto diverso, ho ritenuto necessario dare questo riassunto striminzito dell’articolo di Martin West, fra l’altro editore del bel frammento di Saffo trascritto sopra, sull’autenticità del quale ci sarà da discutere a lungo insieme a un altro attribuito alla poetessa greca, presente nel papiro di un collezionista privato, edito nel 2014 dal grecista inglese Dirk Obbink. Di quest’ultimo ho parlato in un articolo del saggio L’Umanesimo, la grande beffa di Cecco Angiolieri (ilmiolibro.it, Siena 2014, pp. 7-11).
A occuparmi della questione omerica, che mi aveva interessato e anche un po’ annoiato in un corso universitario durato oltre un anno negli anni Cinquanta, sono arrivato tramite la questione dantesca, ignorata da tutti i filologi romanzi, nei cui risvolti si cela a mio parere una grande beffa letteraria giocata dal giullare colto senese Cecco Angiolieri al suo vecchio amico e alunno Dante, divenuto il suo più fiero nemico.
Circa otto anni indietro, grazie alla mia buona conoscenza del senese antico ho scoperto che le opere minori in volgare attribuite all’Alighieri sarebbero dei falsi di Cecco, spinto a vendicarsi del poeta fiorentino, suo vecchio amico e alunno, che per il forte odio l’aveva bollato nella Commedia come goloso, sodomita, poeta superato e falsario, senza menzionarlo sotto il suo vero nome, ritenuto immondo e indegno di figurare nel poema sacro.
Partendo da quei falsi ho scoperto che il senese, il cui pseudonimo più noto è quello di Giovanni Boccaccio, ha composto altri falsi innumerevoli in greco, in latino e in varie lingue europee delle origini per attuare un piano letterario imponente che appare una beffa titanica nei confronti di quella a noi nota come cultura umanistica, che spazia da Omero fino a quasi tutto il Trecento e che comprende anche parte delle sacre Scritture. Ho pubblicato al riguardo saggi e articoli sui quali nessuno finora ha detto o scritto una sola parola.
Chi ha voglia di saperne di più non ha che da leggere quanto ho pubblicato nel mio sito internet (www.menottistanghellini.com) e nella rivista regionale toscana Le Antiche Dogane. Lì ho detto come la penso. Se si vuole che tutto resti come prima per interessi vari, non c’è che da continuare a fare come si è fatto finora, ma l’intellighenzia culturale europea, se non intende confrontarsi con nuove ipotesi, rischia di rimanere molto indietro.
Che sulla questione dantesca io abbia ragione me lo dice un fatto: seguendo le mie congetture, la Commedia per la prima volta da secoli sta cambiando aspetto. Fra breve ne parlerò addirittura come di poema dell’odio.
Ora cominciano a intravedersi molto più nette le vere motivazioni che spinsero l’Alighieri a comporlo, ma la grande novità è che il nuovo personaggio di Cecco, di cui finora nessun commentatore aveva affatto subodorato la presenza, trovi soprattutto nella prima cantica il proprio regno apparendo quasi una specie di matrioska al centro di un complicato gioco di specchi che ne rimandano l’immagine. Cecco è il nuovo personaggio inatteso che grazie alla mia conoscenza dell’idioma senese antico, partendo dalle cosiddette opere minori di Dante in volgare, sono riuscito a scoprire nei gironi infernali della Commedia.
Se non ho preso abbagli in quella che ho chiamato la questione dantesca, c’è un buon novanta per cento di probabilità che abbia ragione anche a sostenere di aver risolto di forza la questione omerica, dietro la quale si cela la presenza dello stesso falsario che nell’ultima parte della sua vita di esule si fece chiamare Giovanni Boccaccio. Per ora non ne sono molto sicuro, ma è probabile che il sommo poeta abbia capito che anche l’Eneide fosse un falso del suo grande amico-nemico Cecco, il suo vero maestro senese, non fiorentino. E allora il personaggio stesso di Virgilio finirebbe per cambiare aspetto insieme a molte altre cose nel poema sacro.